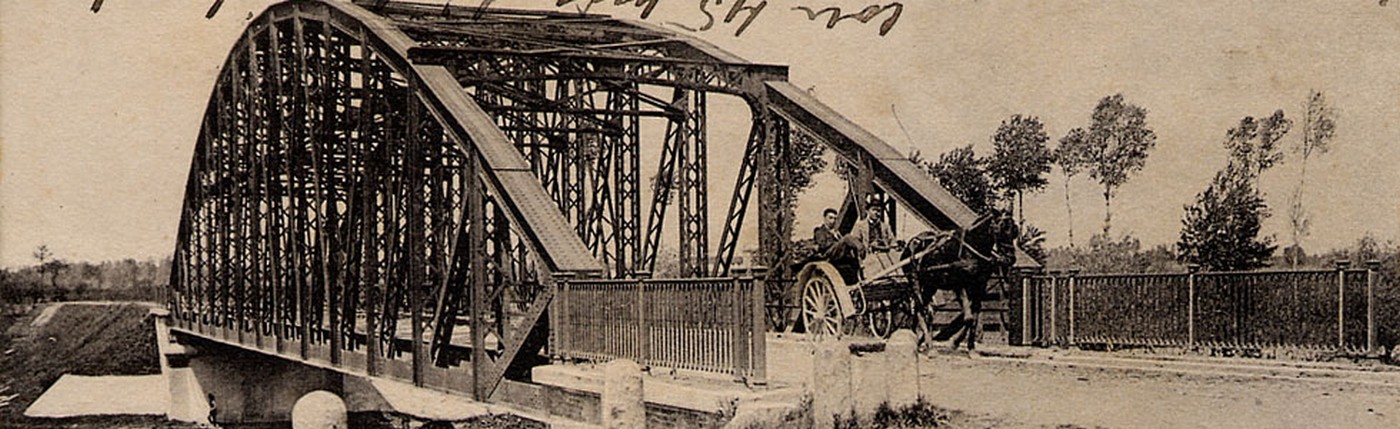Erano mesi (o forse anni, chi si ricorda più) che non usciva un articolo su Quinzano nel Giornale di Brescia. Finalmente venerdi 6 giugno 1997 a pagina 13 un trafiletto sulle iniziative estive della Biblioteca comunale, a firma «G.M.A.» (Gian Mario Andrico, suppongo). Niente da dire sulle preziose proposte della Biblioteca. E tanto meno sulle meritorie intenzioni dell’assessore a far sì che «la biblioteca penetri con metodo e, perché no, in maniera iterata in ogni ambito: nelle strade, dentro ai bar, sulle piazze», con l’ambizione di divenire «il pane quotidiano dei più giovani e ricettivi spiriti» (sarebbe già tanto se un po’ di cultura “penetrasse” nelle sedi appropriate, ma non siamo pignoli).
La sferzata più acida l’articolista la dà tra parentesi, quasi in esordio: «Sono in molti – secondo lui – a chiedersi perché questa borgata sia un po’ lenta nel proporre e alimentare cultura». Eufemismo. E poi, dove saranno mai quei “molti” che se lo chiedono: probabilmente non a Quinzano, per quel che mi risulta.
Certo l’affermazione del Giornale di Brescia non è gratuita. E, del resto, anche il semplice porre una domanda sulla qualità, l’intensità, lo spazio della cultura a Quinzano dimostra l’aspettativa che si ha all’esterno nei confronti del nostro paese. È probabilmente una attesa che deriva da una discreta conoscenza, non tanto delle persone forse, ma degli ambienti quinzanesi dove la cultura ha lasciato nel tempo la sua impronta; e da una sensazione più o meno fondata del ruolo che Quinzano ha rivestito nella storia passata della Bassa, tanto sul piano politico, sociale, economico, quanto su quello del pensiero e della creatività, sia al proprio interno che in proiezione verso il mondo di fuori. Insomma: un ruolo storico cui stiamo venendo decisamente meno, e – guarda caso – proprio in tempi di schiamazzate rivendicazioni delle autonomie locali. Come se la dimensione della cultura non fosse quella che giustifica ogni altra forma di identificazione di una comunità.
Tra i segnali di questo degrado, almeno tra i più vistosi, potremmo metterci anche quella sistematica assenza dai mezzi di comunicazione di cui si parlava all’inizio. In un mondo, come si usa dire oggi, dalle coordinate sempre più virtuali, esiste soltanto chi sa far sapere che esiste, e il resto scompare.
Visibile e invisibile
Rimanendo al nostro piccolo territorio e all’esempio del Giornale di Brescia, c’è stato un tempo in cui Quinzano aveva il suo bravo corrispondente, e ogni tanto (in qualche periodo di effervescenza ogni poco) il suo bravo trafiletto nelle cronache della Bassa. Oggi ci sono paesi, non molto distanti né molto diversi dal nostro, che occupano quotidianamente almeno mezza pagina; altri che compaiono due o tre volte la settimana; altri ancora che di quando in quando guadagnano l’onore della stampa perché è uscito il bollettino locale, o perché un amatore ha esposto quattro fotocopie, o perché spolverando un quadro si è rinvenuta una firma di fine ‘800.
Non per dire, ma in queste stesse righe, da qualche mese in qua, si sono attribuiti, quasi sempre con buona certezza, due cicli di affreschi del ‘600, oltre una decina di dipinti dei secoli XVI-XVIII ancora esistenti, due ancone lignee d’altare, e poi si sono offerte nuove notizie sull’organo di San Rocco, sulla chiesa parrocchiale, su antichi notabili del paese, persino sulla presunta nascita quinzanese di uno dei più fecondi operisti italiani del ‘600. Risultato: meno di zero.
Le autorità, che avrebbero come compito anche quello di custodire e magari promuovere l’immagine del paese, sono probabilmente affaccendate in altre faccende, senza dubbio più importanti, come per esempio «regalare momenti di fattiva riflessione e offrire strumenti che siano in grado di fornire risposte culturali», allo scopo di rendersi presenti «là dove, di solito, si parla di tutto meno che di quanto sia bello leggere un libro» (parola d’assessore).
Per carità, non vorrei dar l’impressione di smaniare per un paio di righe in cronaca di costume. Non è scritto da nessuna parte che un paese deve avere sui giornali uno spazio proporzionale al suo rilievo nella provincia (ci mancherebbe la par condicio anche qui dentro), o addirittura uno spazio comunque sia. Ciò non toglie che l’invisibilità di Quinzano è equivalente alla sua inconsistenza civile e culturale ai nostri giorni.
Questa considerazione, se da un lato fa salvo il principio di giustizia distributiva (al nulla tocca il nulla), dall’altro dovrebbe far riflettere almeno «i più giovani e ricettivi spiriti».
Questione di immagine
E allora proviamo a riflettere. L’immagine che noi diamo di noi stessi non è meno importante di quello che noi siamo, non tanto perché dovremmo apparire diversi dalla nostra realtà vera, quanto piuttosto perché non è giusto mostrarsi agli occhi degli altri per meno di ciò che si è e si vale. In altre parole, se il nostro paese – per mero esempio – possiede un passato dignitoso e un presente inerte, non è giusto che si metta in mostra sfoggiando odierne glorie inesistenti, ma non è altrettanto giusto che si dimentichi di valorizzare meglio che può tutto quanto è valorizzabile nella sua storia remota e recente.
Del resto, nell’era dell’informazione dilagante, non conta ciò che si è, ma come ci si vende (scusate la schiettezza); e chi non sa vendersi bene (nel senso della valorizzazione dei pregi reali, non della mistificazione – lo ribadisco) è annientato, cancellato.
Come si fa, dunque, a vendersi bene? Mi limiterò al campo umanistico che è il mio, così non offendo nessuno. Anzitutto bisognerebbe smetterla di dare dell’ignorante alla gente, o di considerarla tale: la gente non va alle mostre, ai concerti, alle presentazioni dei libri, alle conferenze, perché non è stata abituata, educata a farlo; e non è stata abituata perché mostre concerti e conferenze di solito non ci sono. E non si dica che, quando li abbiamo fatti, non è venuto nessuno, perché un’iniziativa sporadica, anche con gran dispiego di mezzi ed energie, non costruisce una abitudine culturale, che invece va creata col tempo e la costanza.
Ma tempo e costanza sono elementi che appartengono a un progetto culturale. E un progetto culturale è parte essenziale e frutto di un progetto politico, inteso come programma di ampio respiro, elaborato sulle caratteristiche autentiche di una comunità, per promuoverne le qualità e potenzialità positive, rimediando insieme ai suoi eventuali difetti. Naturalmente, come il lettore avrà intuito, quando parlo di progetto politico non penso solo all’ambito strettamente connesso con la pubblica amministrazione, ma a tutti gli ambienti che in qualche modo sono preposti a pensare e attuare progetti di un certo respiro sociale in un paese: la biblioteca, la scuola, i gruppi di volontariato sociale e culturale, la parrocchia.
Un restauro in metafora
Faccio un esempio – ancora un mero esempio. Quando si vuol restaurare un quadro, si può procedere in modi diversi: si può passarci sopra alla bell’e meglio una spugna bagnata; si può farlo ridipingere in fretta per ravvivarne i colori; oppure affidarlo a un restauratore competente, ma poi ricollocarlo nelle medesime condizioni che avevano prodotto il degrado; oppure ancora progettare un organico intervento di recupero, che preveda un ripristino perfetto del dipinto, ma anche una sistemazione adeguata e un controllo assiduo e scrupoloso del suo stato nel tempo. Ognuno di questi interventi rivela un atteggiamento differente di fronte al problema, che muove da intendimenti diversi, finalità diverse, e da una diversa capacità di leggere e interpretare il mondo in cui si vive.
La fretta e la superficialità rivelano un profondo disinteresse per l’oggetto che si ha in cura: non importa che fine farà nel prossimo futuro; non importa se l’intervento, dietro una patina di rinfrescatura, ha fondamentalmente compromesso l’opera d’arte; l’importante è quello che si vede adesso, salvarsi la faccia e coprirsi le spalle, guadagnarsi a buon prezzo un consenso pubblico che garantisce una fetta di potere, o la tranquillità di poterlo esercitare senza renderne conto. Allora l’opera d’arte o, fuori di metafora, la storia della comunità, la sua vita, diventa non più la finalità dell’impegno comune, ma lo strumento del successo di un individuo o di un gruppo, il gradino su cui arrampicarsi per arrivare due dita sopra gli altri.
Un buon restauro, al contrario, è lavoro di fatica e di pazienza, che non paga nell’immediato, e talora nemmeno nel progredire del tempo. Occorre anzitutto avere una visione chiara d’insieme dell’ambiente in cui l’opera si trova; occorre sentirla come cosa propria, come parte di sé, non come merce di scambio. Il compito di rimediare tecnicamente agli sfregi del tempo tocca naturalmente agli esperti, a chi lo sa fare bene; ma dare un senso a questo operare è compito di tutti, e quindi in particolare di chi, rappresentandoci, ci deve rappresentare anche in questa ricerca del senso, e magari deve aiutarci e fornirci gli strumenti adeguati, se questo senso dell’operare non siamo in grado di scoprirlo da soli.
Alla ricerca di un senso
E il senso di un’opera d’arte è quello di essere un frammento vivo in un mondo di persone vive. Se dunque un’opera d’arte è viva, non si può pensare che, rimpinzata una volta per tutte, non abbia più bisogno di cure e di attenzioni: sarebbe come ingozzare ben bene un bambino, per poi lasciarlo a digiuno, perché tanto ha mangiato per un po’. Sembra una barzelletta, eppure è quello che succede di norma quando si interviene sulle memorie del passato senza un piano dotato di senso.
Tanto rumore per una scoperta, una ristrutturazione, un restauro; trombe e timpani per celebrare le personalità che han messo mano a tanta e tale impresa (di solito con soldi non loro, ma questa è una malignità); per poi lasciare che tutto vada di nuovo a catafascio, e questa volta per sempre. A quel punto, tanto valeva lasciare tutto nascosto, visto che così si era conservato fino ai nostri giorni, e dunque così poteva conservarsi per altrettanto tempo, fino a trovare una civiltà un po’ più sensata della nostra.
Però, pensare a un atteggiamento – diciamo così – di restauro permanente, a una attenzione quotidiana per le condizioni dei nostri oggetti culturali, mi verrebbe da dire per il loro benessere, allo scrupolo di creargli intorno un ambiente vivace di interesse oltre che sano di strutture, vuol dire ripensare un progetto di storia a piccoli passi momentaneamente poco vistosi, programmare tempi troppo lunghi per i velocisti dal fiato corto, dirottare i fitti rivoli dei bilanci in uno stillicidio che non premia con soddisfazioni immediate: meglio centinaia di milioni tutti in un colpo che pochi spiccioli un anno dopo l’altro: se no, come si fa a farsi un nome che duri.
Poi, se sono abili, trovano sempre il modo di convincerti che non si poteva diversamente; e, se si poteva, non ne valeva comunque la pena; e, se ne valeva la pena, chi comanda alla fine non sei tu. E noi zitti, per amor di tranquillità. E intanto il tempo passa e il degrado si fa irreversibile.
Cronaca di una scazzottata
Ora bisogna però sollevare un po’ l’umore, dopo discorsi così seriosi.
Abbiamo parlato di cronaca e di classi dirigenti dei piccoli centri. Non c’erano un tempo giornali che diffondessero capillarmente la cronaca locale, ma episodi curiosi non ne mancavano. Il fatto è che le modeste vicende di paese rimanevano confinate ai testimoni diretti e ai pettegolezzi dei curiosi. A meno che non riguardassero persone, non dico di alto rango, ma appartenenti alle classi sociali dominanti: la nobiltà, il clero, la ricca borghesia. In questi casi si avevano strascichi disciplinari o addirittura giudiziari che, a seconda del peso effettivo nella comunità dei protagonisti e dei loro protettori, potevano raggiungere le stanze del vero potere. A queste trame di protezioni eccellenti dobbiamo la notizia degli episodi che narreremo brevemente.
I documenti che presentiamo sono due lettere dell’arciprete di Quinzano don Apollonio Busi (1738-1772) al vicario generale del vescovo di Brescia, datate 16 e 18 marzo 1742. Sono conservate all’Archivio Vescovile di Brescia, in un fascicolo intestato alla parrocchia di Quinzano: fonte al di sopra di ogni sospetto. Ecco la prima:
Illustrissimo e Reverendissimo Signor Signor Patrone Collendissimo
Quinzano 16 Marzo 1742
Intenderà da Andrea Manente mio Parocchiano un accidente avvenutogli ieri con un Sacerdote di questa Terra. Con tutto rispetto uniglio [=umilio] il caso à Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima assicurandola che il Religioso Don Pietro Cominetti è stato l’offeso, ed è d’ottimi costumi e di vita esemplare, e quasi necessariamente s·è douuto difendere. Ed in questo incontro mi do l’onore d’arricordarle l’umilissima servitù mia, ed intiera ubbidienza. E col più profondo mio rispetto mi protesto
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Vicario Generale
Vmilissimo Diuotissimo Obligatissimo servitore
Appollonio Busi Arciprete
Con questa lettera, piuttosto enigmatica, l’arciprete previene il vicario vescovile circa la denuncia di un certo parrocchiano Andrea Manente, per un «un accidente avvenutogli ieri con un Sacerdote di questa Terra», di nome don Pietro Cominetti. Il parroco avverte che il Cominetti è l’offeso, decanta le sue esemplari qualità e insinua che «s’è dovuto difendere».
Le informazioni più dettagliate sul misfatto le abbiamo però dalla seconda lettera, di due giorni posteriore.
Reverendissimo Signor Signor Patrone Collendissimo
Quinzano. 18 Marzo 1742
Ho creduto superfluo moltiplicar l’attedio à Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima nel raggualio del caso accaduto tra il Reverendo Signor Don Pietro Cominetti, ed Andrea Manente, perché raccontatomi dal Manente stesso chiaramente rilevai aver questi torto. Ma bisogna che abbia diversificato, o alterato il racconto alla presenza di Monsignor Vicario Generale. Il fatto però è siccome l’ho rilevato da tre testimonj tra quali v·è un Frate. Passeggiava dicendo l’Offizio il Religioso Cominetti per un sentiero da molto tempo libero, e praticato da tutti, quandecco esce il Manente quale tiene à Massaro i beni sù quali evvi il sentiero, e villanamente dice «non à voi Padre, ma à voi Signor Don Pietro vi dico tornate indietro, che da qui non voglio passiate». Allora il Religioso soggiunse «mi meraviglio cosa avete meco o con la Casa mia», «tanto è» replica il Manente addietro, e nel cosi dire, dá di mano ad una pertica, e minacciosamente l’alza, onde il Prete torna addietro, e costui lo accompagna per longo tratto sempre colla pertica alzata, e con parole ingiuriose. Il Religioso vedendosi dopiamente affrontato si rivolge, e prende la pertica dalle mani di costui, e tenta di darle [=dargli] una bastonata, ma impedito dal tabarro non li vien fatta. Onde il Manente li salta addosso, e presolo per i capegli lo tira in terra, e cosi or l’uno or l’altro sotto: resta però superiore il Manente, che con un ginocchio teneva calcato ed oppresso il Prete. Corse gente, e si divisero venendo sangue dal naso in abbundanza al Religioso. S’avverta, che il secolare è uomo che di quando in quando incontra disgusti con qualchuno, e ha del temerario. Il Sacerdote ha ricevuto l’uffizio fattogli per il perdono, ma intende, che costui sj [=sia] condannato à quella Elemosina, che da me sarà giudicata propria, ed io ho detto à quella, che determinerà Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima. Attenderò adunque ciò Vostra Signoria Reverendissima m’avviserà per spedire costui aggiungendo il Prete assolutamente che quando non sj condannato in qualche cosa per l’esempio farà correre dinunzia. Iscuzi l’incommodo, e mi dò l’onore nell’incontro di arricordarle il mio rispetto, e che sono
di Vostra Signoria Reuerendissima Divotissimo Obligatissimo servitore
Appollonio Busi Arciprete
L’arciprete esordisce giustificando il suo silenzio sulla vicenda nella comunicazione precedente, perché a suo parere il caso era palese, a dire dello stesso incriminato Manente. Questi tuttavia doveva aver deplorevolmente falsato il racconto delle responsabilità nel suo colloquio con il vicario generale: dunque necessitava un chiarimento, che don Apollonio delinea sulla base del racconto di tre testimoni «tra quali v’è un Frate», presumibilmente del Convento di Quinzano.
A questo punto inizia una deliziosa narrazione, rapida e vivace, con tanto di fulminee battute di dialogo (le virgolette nell’originale non ci sono: qui le abbiamo inserite noi per facilitare al lettore la comprensione). Non aggiungeremo nulla alle parole del Busi, tranne poche indicazioni: “Padre” è il frate, poi anche testimone; “il religioso” è evidentemente il Cominetti; “il secolare” infine è il Manente, affittuale (massaro) dei beni su cui correva il sentiero privato percorso dal prete in compagnia dell’anonimo frate; il “tabarro” che impicciò le mani al prete è il suo mantello.
Naturalmente lo zelante arciprete conclude la sua relazione con un giudizio non troppo lusinghiero per il Manente, mentre il freddo complimento riservato al Cominetti e alla sua volontà di perdono sembra adombrare sotto sotto una solenne tirata d’orecchi per l’incauto e manesco sacerdote.
Corsi e ricorsi storici
Chi credesse che questo episodio fosse un caso davvero eccezionale, si ricrederà sapendo che lo stesso faldone del medesimo Archivio Vescovile conserva un altro documento, questa volta del gennaio 1666, riferito a un caso non molto dissimile.
È un foglio contenente anzitutto in lingua italiana la descrizione dell’episodio increscioso, che ha per protagonisti da una parte il nobile bresciano Ottavio Provaglio, feudatario di Monticelli d’Oglio, e dall’altra il prete quinzanese don Giovanni Battista Bertola. Ecco il testo, indirizzato presumibilmente anch’esso al vicario generale vescovile di allora:
Illustrissimo e Reverendissimo Signore
Il Signor Ottavio Provaglio, gentil huomo bresciano, haveva disgusto col Reverendo Don Giovanni Battista Bertola, da Quinzano, Prete della Diocesi di Brescia. Detto Don Giovanni Battista fece passar officio col signor Provaglio, il quale non si acquietò pienamente, ma rispose à chi lo passò, che, essendo il Bertola sacerdote, non l’haverebbe offeso, ma che dovesse stargli fuori de gli occhi. Alli 28 di Decembre, passato, festa de gl’Innocenti, mentre il signor Provaglio era nella Terra di Monticelli, si partì dalla sua Casa, et andò nella vicina del Reverendo Curato di quel luogo. Dopo sovragiunse il Reverendo Bertola, armato d’arcobugio. Havendolo veduto il signor Provaglio, uscì, commosso [=scosso, adirato] dalla Casa del Curato, e diede ordine à suoi huomini, che, uscito che fosse il Reverendo Bertola gli levassero l’arcobugio, e glie lo rompessero sopra la testa, ma incontratosi prima nel signor Ottavio, esso Signore lo assalì, gli tirò un pugno, che lo fece cader in terra et urtar in un muro, onde alquanto si ruppe la testa, e gli diede anche due ò tre pezzate. Pentito il Signor Ottavio di quanto ha commesso, et essendo seguito l’aggiustamento col Reverendo supplica humilmente Vostra Signoria Illustrissima dell’ Assolutione pronto etc. alla qual etc.
Auguste protezioni
Qui non si tratta solo di mani e di pertiche, ma di “arcobugi”: e non è cosa da poco che all’epoca ci fossero pretini di campagna che giravano con lo schioppo a tracolla, e con intenzioni non propriamente caritatevoli. Buon per lui che il signor Provaglio si accontentò di mollargli un pugno solenne e «due, ò tre pezzate» (pesàde, naturalmente). È abbastanza intuibile la causa remota, benché generica, del contendere: tra i due covava un inveterato “disgusto”, una discordia; non è invece chiaro il movente particolare dell’episodio, ricondotto al fatto che il prete Bertola «fece passar officio», il che non acquietò pienamente il Provaglio di fronte «à chi lo passò». Forse si intende una sorta di scusa formale per i dissidi trascorsi, inviata dal sacerdote al nobile tramite un intermediario. Il pentimento del manesco signore è l’unico particolare privo di colore nella narrazione.
La questione, comunque, non si chiuse così pianamente come quella del 1742, poiché nel medesimo foglio dove è riportato il testo sopra trascritto sono copiati altri due solenni atti ufficiali in latino.
Il primo, dato dal palazzo apostolico presso San Francesco alla Vigna in Venezia il 13 gennaio 1666, anno XI del pontificato di Alessandro VII, è un rescritto dell’arcivescovo di Atene mons. Giacomo Altoviti, nunzio apostolico presso il Serenissimo Dominio: non c’è bisogno di ricordare al lettore che Venezia all’epoca era una nazione autonoma, e dunque sede di ambasciate straniere, compresa quella vaticana. La lettera, indirizzata al vicario generale di Brescia, allude a un memoriale sulla vicenda corredato di una supplica. Quindi l’alto prelato, consapevole di non essere al corrente dei particolari dell’incidente, e pur desideroso di giovare in ogni modo a quanti ricorrono a lui e, per suo tramite, alla sede romana da lui rappresentata, per l’autorità apostolica di cui è dotato delega alla discrezione del vicario bresciano di risolvere la lite nelle opportune sedi ecclesiastiche e civili, provvedendo ad assolvere l’offensore, non senza previa salutare penitenza per la sua colpa secondo le norme di legge. Dunque il Provaglio, che di famiglia era nobile veneto, aveva fatto ricorso al rappresentante della Santa Sede nel Veneto Dominio contro la denuncia del Bertola.
Il terzo degli scritti riportati nel foglio dell’Archivio Vescovile è la sentenza pronunciata il 16 gennaio da Carlo Antonio Luzzago, dottore d’ambe le leggi, protonotario apostolico, arcidiacono e vicario generale del vescovo di Brescia. Costui, letto il rescritto del nunzio Altoviti presentatogli dal nobile Provaglio umilmente genuflesso ai suoi piedi in attesa della riconciliazione, lo assolve e libera dalla scomunica in cui era incorso per l’offesa recata al prete Bertola, ingiungendogli una salutare penitenza, nelle forme previste dalla chiesa.
Con la magnanima sentenza, sollecitata dalle altissime sfere della gerarchia ecclesiastica, si conclude anche questa vicenda incresciosa di soprusi e di violenze tra membri di classi diverse e contrapposte nell’ambizione del privilegio e del potere.
Quanti ancora oggi aspirano a erigersi monumenti più eterni del bronzo (come direbbe Orazio) non dovrebbero dimenticare che il loro nome nella storia l’hanno inciso a chiare lettere anche i signori Provaglio e Bertola, Cominetti e Manente. E riguardo a ciò che i posteri dovrebbero dire di noi, non saprei se possa valere il detto che vale tra i viventi: «Parlino bene, parlino male, purché parlino».
Tommaso Casanova
(L’Araldo Nuovo di Quinzano, a. V n° 43, giugno 1997, pp. 9-10)
Riferimenti documentari e bibliografici
- Archivio Storico Diocesano: Archivio Vescovile, fasc. "Quinzano"
- G.M.A. [Andrico, Gian Mario], 1997
“A Quinzano libri arte e sette note. Le prossime iniziative della Biblioteca, Giornale di Brescia, venerdi 6 giugno 1997, p. 13